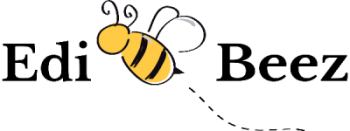La prima grande mostra veneziana dedicata a Italico Brass, dalla sua morte avvenuta il giorno di San Rocco del 1943, e alla sua visione della città: l’artista che tra Otto e Novecento apre alla modernità e alle suggestioni della pittura impressionista, per raccontare una Venezia inedita, viva, pulsante, popolare. Un’occasione gustosa: un pittore internazionale, fuori dal provincialismo dei pittori locali, il più noto veneziano ai suoi tempi, dimenticato in Italia. Il focus dell’esposizione è sulla città di Venezia a lui cara, per la quale provò quasi una devozione nonché soggetto prediletto della sua arte.
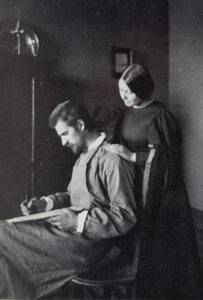
La sua Venezia: non è monument

ale, né bozzettistica e neppure nostalgica. Nessun rimpianto del passato quanto la voglia di immergersi nella città vissuta. Per questo è stato definito il pittore della gente, con una grande attenzione ai bambini molto presenti nei suoi dipinti e la ricerca di guardare la città proprio attraverso gli occhi degli altri.
L’occasione è preziosa per conoscere o riscoprire un pittore acclamato in vita e nel dopoguerra e quasi dimenticato per oltre sessant’anni a Palazzo Loredan-Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti fino al 22 dicembre, del quale tra l’altro si sa poco.
L’esposizione raccoglie 110 opere, metà delle quali almeno mai viste prima dal pubblico, e l’opportunità è anche quella di scoprirne l’originalità pittorica in relazione alla pittura del tempo e della sua terra oltre che di ritrovare una Venezia ormai perduta, quando ancora apparteneva ai veneziani. Forte è l’eredità degli Impressionisti per l’attenzione all’intimità del quotidiano e alla restituzione frizzante di paesaggi e scorci, alcuni dei quali probabilmente fotografati – è stata ritrovata una macchina nel suo studio ed era una pratica in uso presso i ‘cugini’ d’Oltralpe – e poi dipinti come nel caso di una Regata in mostra, che sembra di vivere in presenza.

Al grande “poema pittorico” che Brass, nel corso degli anni, realizza intorno a Venezia è dedicata la mostra curata da Giandomenico Romanelli e Pascaline Vatin, promossa dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia e dall’editore lineadacqua, presieduta da Luca Zentilini, l’ideatore, che ha stampato il catalogo (grafica e fotografia molto eleganti) in Campo Santo Stefano, dov’è presente una parte cospicua del lascito di famiglia. Organizzata come una mappa della città lagunare, ci consente un viaggio che parte da San Trovaso e dalla casa dei Brass (dov’è tuttora la dimora della famiglia) e in otto tappe attraversa la città fino all’Abbazia Vecchia della Misericordia, acquistata da Italico nel 1918, coronando un suo sogno.

Principale sponsor Majer, con dieci punti vendita in diversi luoghi strategici della città con la produzione di pane e pasticceria artigianale e il caffè torrefatto e confezionato, di cui due ristoranti.
Italico Brass, nasce a Gorizia nel 1870 e si trasferisce successivamente a Monaco e poi a Parigi, per rientrare successivamente a Venezia nel 1995, anno nel quale si sposa, rimanendovi. Vi morirà nel 1943 e la sua arte chiude un’epoca e ne apre un’altra, assolutamente inedita.
Certamente nella maturazione della personalità artistica di Brass – che Elio Zorzi, in occasione della retrospettiva dedicatagli nella Biennale del 1948 – la stessa che vide esposti anche gli Impressionisti e la collezione Guggenheim – definì “un fenomeno particolare, un caso isolato” per il suo tempo – appaiono fondamentali gli anni della formazione: prima all’Accademia di Belle Arti di Monaco di Baviera e poi a Parigi, dove il giovane Italico risiedette per circa sette anni frequentando accademie e integrandosi nei circoli variegati del mondo impressionista. Del periodo parigino per altro si conosce ben poco anche perché ci sono giunte solo poche tele che però restituiscono la vita parigina.

Si sa che ebbe come compagno di stanza l’artista russo emigrato a Parigi Vigdoff che divenne poi suo cognato con il quale espose in diverse mostre e vinse dei premi. Il futuro cognato era ben introdotto in città e probabilmente inserì anche Brass nella vita culturale: il risultato fu straordinario visto che l’artista si legò alla prima galleria della città, quella di Georges Petit.
Come accennato, Brass appare sulla scena chioggiotta e veneziana nel 1895, di ritorno da Parigi, e si impegna subito come un protagonista. Presente alla Biennale fin dalla sua prima edizione, la sua sarà una partecipazione costante e molto apprezzata, tanto da meritargli quella qualifica di “Pittore di Venezia” che già a Parigi lo aveva contraddistinto.
Chioggia e Burano furono le mete delle sue prime incursioni veneziane. Chioggia in quegli anni trasmetteva il fascino della laguna richiamando pittori italiani e stranieri e qui si ritrovava il fior fiore dell’arte veneziana: Luigi Nono, Ettore Tito e il friulano Umberto Veruda e Pieretto Bianco, Mosè Bianchi, Emilio Gola e Pietro Fragiacomo.
Certo che fin dalla sua prima personale alla Biennale del 1910 – quella che segna l’apertura alle correnti più innovative e fertili dell’arte europea – il successo e l’affermazione del pittore sono definitivi. Ad essa seguiranno mostre collettive e ricche personali in molti paesi, di qua e di là dell’Atlantico, e soprattutto esposizioni nei paesi nordici.

Strano oggi pensare a questo personaggio sconosciuto, non fosse per il nome del celebre ‘erede’ Tinto Brass, che partiva per New York dov’era di casa.
L’esposizione è anche un’occasione per scoprire la poliedricità di un personaggio che non è stato solo pittore, quant’anche collezionista di arte antica soprattutto veneziana e protagonista culturale della vita della città, membro ad esempio di commissioni per il restauro. Fu tra l’altro promotore di una delle prime grandi mostre su Tintoretto, Tiziano e Veronese con Nino Barbantini.
Come ha sottolineato Romanelli un critico lo definì un ‘innesto’ di Monet e Guardi, definizione che ebbe molta fortuna sebbene un po’ riduttiva che però svela la complessità dell’uomo e forse proprio in questa sta l’originalità della scelta espositiva e l’interesse che può destare nel pubblico.

È stato inoltre reporter di guerra, illustrandola con uno stile che, pur rispettoso della drammaticità dei soggetti, conserva una sua delicatezza, solarità e speranza – come ci ha raccontato il curatore – come nell’opera Rifugio durante un bombardamento aereo del 1915-1916, dove vengono in mente alcuni toni della pittura di Lorenzo Viani, sebbene il tratto del maestro veneziano non perda mai la sua morbidezza.
A Venezia egli deciderà di lavorare e vivere nell’abitazione di San Trovaso, con la moglie russa Lina Rebecca Vigdoff, incontrata a Parigi e allora studentessa di medicina e frequenterà gli ambienti e le persone che contano – grandi imprenditori, intellettuali, gerarchi e artisti – o coinvolto in iniziative di arredo e scenografia del Canal Grande in occasione delle più importanti festività.
Passeggiando idealmente per Venezia con Italico Brass incontriamo la sua passione per i ponti provvisori che si mettevano in determinate occasioni, rispettivamente il Redentore, quello della Salute e dei Morti, all’isola di San Michele, dove c’è il cimitero di Venezia, di fronte a Cannaregio.
Immagine della mostra, San Marco Caffè Lavena dipinto nel quale si svela l’eredità degli Impressionisti e ad un tempo la sua originalità, riportando l’atmosfera all’intimità quotidiana in una sintonia, come ha fatto notare il curatore, che lo avvicina a Raffaelli – che conosce e ritrova in occasione della II Biennale di Venezia – che esponeva con gli Impressionisti senza riconoscersi in essi.
Colpisce l’attenzione riservata al Lido in un periodo nel quale cominciano ad essere pubblicati libri guida per un incipiente turismo balneare. Le atmosfere soffuse restituiscono il clima d’antan e fanno pensare ad altre marine del periodo da quelle di Ulvi Liegi, a quelle di Moses Levy.
Sempre a Venezia acquisterà infine, come accennato, e s’impegnerà nel lungo restauro della diroccata e semi abbandonata Abbazia Vecchia della Misericordia, che diventerà sede del suo atelier e della sua celebre collezione d’arte antica – a lui, che fu anche mercante d’arte, si devono tra l’altro la riscoperta di artisti come Magnasco in collaborazione con Benno Geiger e la valorizzazione di autori come Arcimboldo e Pordenone – oltre che il fascinoso e ascetico luogo d’incontro di artisti, giornalisti, intellettuali e maggiorenti. L’Abbazia, acquistata dalla Soprintendenza negli Anni Settanta del Novecento, è oggi il laboratorio di restauro delle Gallerie dell’Accademia.
Nei suoi dipinti l’artista guarda a Venezia senza precostituite gerarchie: “il caffè Florian a piazza San Marco – scrivono Romanelli e Vatin – ha la stessa dignità delle famiglie popolari e dei loro pique-nique al Lido; la processione a san Trovaso e la partita di calcio a sant’Elena; gli scaricatori di sale alle Zattere e i burattinai a san Barnaba. Evidente è l’interesse per certe aree periferiche della città come nella Venezia del Baron Corvo, gli interramenti delle barene e le aree verdi di una città che cresce e si espande diventano soggetti amati e riproposti. Per non parlare dei gruppi di impiraperle sedute a chiacchierare nel campiello di corte Colonna che destano la medesima attenzione della processione in pompa magna delle autorità ecclesiastiche verso il Redentore. Brass è cronista accurato, divertito e partecipe di ogni aspetto della vita quotidiana […] è sempre là con i suoi fogli le sue tavolette per appuntare un volto, un gesto una smorfia; oppure confuso tra la folla che assiste alle regate, rileva lo sforzo dei campioni e la dinamicità di uno sport che è solo ed esclusivamente veneziano. Il ‘pittore di Venezia’ è sempre in servizio”.
La mostra è arricchita dal profumo, creato appositamente da The Merchant of Venice, marchio di profumeria artistica di lusso ispirato all’antica arte profumiera di Venezia e partner dell’evento, che per l’occasione ha ricreato le atmosfere della città lagunare dei primi decenni del Novecento, tra suggestioni dannunziane e orientaliste.
Allo stesso modo le celebri lampade in seta ideate dal contemporaneo Mariano Fortuny, altro simbolo della vivacità creativa, culturale e artistica della Venezia di inizio secolo, richiameranno in mostra gli ambienti dell’atelier di Brass e il gusto del tempo, grazie alla collaborazione con la ditta Fortuny, che perpetua oggi le creazioni di Mariano e della moglie Henriette.
Sostengono l’evento anche Generali Italia, la cantina Biondelli Franciacorta e Siretessile, di azienda manifatturiera per prodotti tessili di alta qualità a Treviso.
a cura di Ilaria Guidantoni