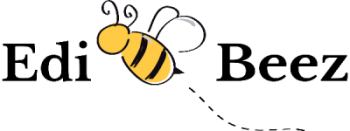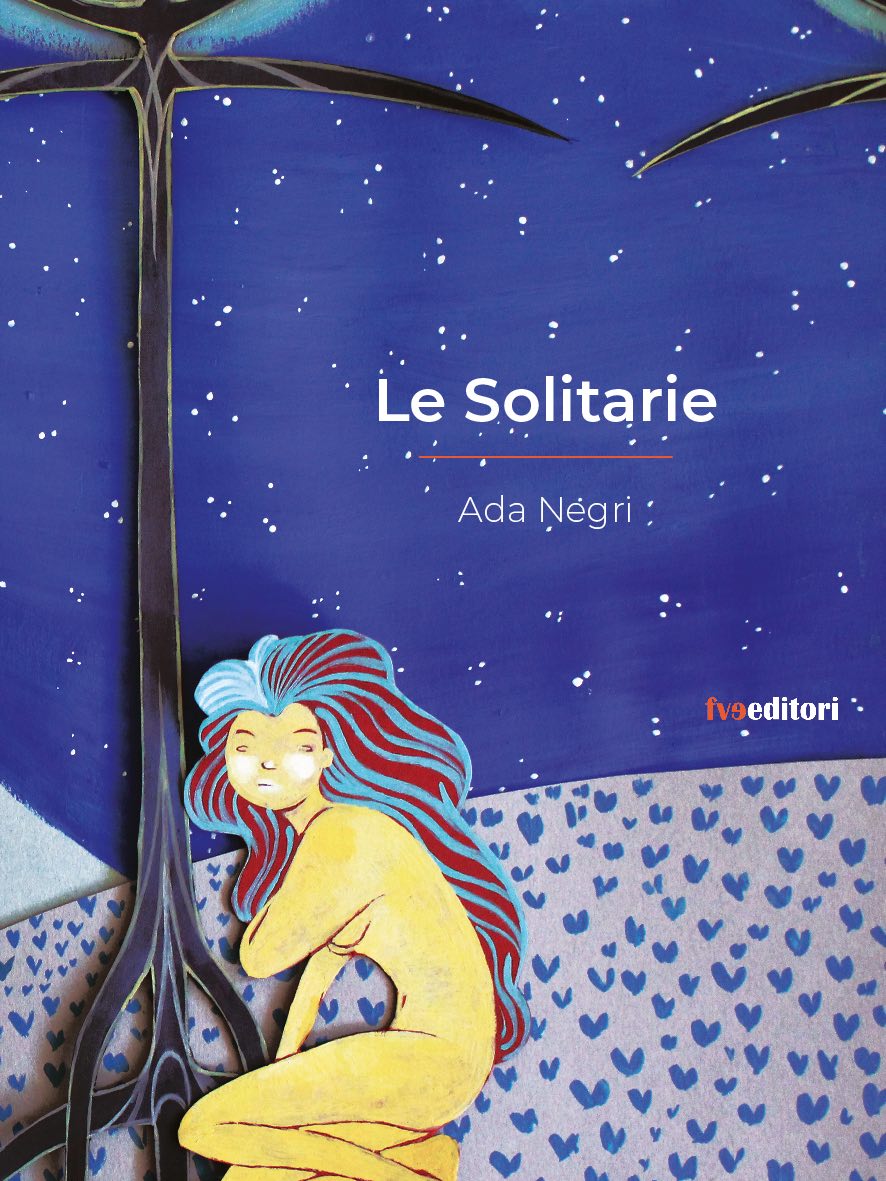
Descrizione prodotto
Un testo dall’impronta veristica, che ricorda il Verga migliore e insieme quella ‘miseria ragionata’ di Émile Zola, con un’elaborazione psicologica più sottile, articolata, che rende il libro ‘gustoso’ e fruibile ancora oggi, a 150 anni dalla nascita della scrittrice che contese il Nobel per Letteratura a Grazia Deledda e fu anche giornalista, scrivendo per il Corriere della Sera.
Il libro tutto al femminile, dedicato alle donne che non riescono ad essere protagoniste della loro vita, che nel loro profondo restano sempre sole oltre che solitarie, anticipa una letteratura di qualità e il dibattito sul femminile, oltre il femminismo e certamente al di là della cosiddetta letteratura rosa, anche la migliore. Un’autrice da riscoprire che la nuova casa editrice FVE Editori, ideata e diretta da Valentina Ferri, ha il merito di portare alla luce con una consapevolezza nuova che toglie ad Ada Negri, la patina del tempo e il pregiudizio di una scrittura per sole donne, ormai datata.
La raccolta è articolata in due parti, la prima dedicata all’ambiente più umile, quello del popolo, di donne semplici e spesso povere, un ambiente che l’autrice ha conosciuto bene, così come quello alto borghese, e che a mio parere è vicino alla lezione di Verga. Come non ricordare in tal senso Nedda, la raccoglitrice di olive? Purtroppo anch’essa fin troppo attuale se pensiamo al dramma del caporalato nelle campagne del sud. La seconda parte è riservata al mondo della città, della borghesia dove la povertà lascia spazio alla miseria, quella interiore e forse siamo più vicini a certi romanzi di Zola come Aux bonheur des dames. In ogni caso è interessante lo sguardo lucido e insieme distaccato della voce narrante.
Ada Negri ha dichiarato che per ognuno dei ritratti di donna, il suo cuore è stato coinvolto, gioendo e soffrendo per ognuna e questo non è in contraddizione con la lucidità di uno sguardo che si pone alla giusta distanza e non prende posizione, non si arroga il diritto di condannare e assolve, ma racconta la vita con curiosità e pietà. Il libro certamente è soprattutto la scrittura, folgorante, con la capacità di catturare il lettore in una sintesi graffiante eppure italianamente impeccabile nello stile. E’ certamente un testo da recuperare per salvare la lingua italiana con una capacità iconopoietica straordinaria, vivace, teatrale, raffinata nell’uso dei termini giusti rispetto alla situazione, che si piega alla voce del popolo senza slabbrare la lingua. Troppo spesso oggi la letteratura descrivendo il sesso ad esempio si fa pornografia anche nel linguaggio mentre la perversione può dare pagine liriche. Ecco Ada Negri riesce in questo, è il Rembrandt della scrittura. Come non ricordare il passaggio dell’ultimo grande racconto dedicato al Denaro quando descrive “La cameriera, una sfrontatella tutta bocca, bazza e maldicenza…”.
Davvero una sintesi strepitosa. Il testo si legge con grande piacevolezza sia per l’incedere, sia per la forza della trama, la compiutezza di ogni racconto, sia per la bellezza della lingua e quella sintesi così contemporanea, che purtroppo oggi si è persa per altro. Si sbrodolano pagine e pagine di romanzi, inultilmente, che viene il sospetto che si vendano a peso. La protagonista dell’ultimo racconto è una solitaria che consapevole si ribella, riuscendo a non essere più tale e, sarà un caso, proprio grazie all’aver studiato da maestra e al praticare la scrittura. Una chiusura che sa di racconto nel racconto.
“Quella bimba! Così libera e così fiera, con un passo così elastico e rapido che c’era da mozzarsi il fiato a volerla seguire, quando divorava in tre salti la strada, dalla fabbrica alla sua casa. Bei capelli, non castani, non rossi, vivi, capricciosi; e due lampade elettriche al posto degli occhi… E parlava di rifare il mondo e l’umanità! ll riso di Veronetta faceva schioccare nell’aria un colpo di frusta. Vicina agli uomini, lontanissima da loro, Veronetta parlava un altro linguaggio”.
Tutti i personaggi femminili sono delle solitarie portando addosso un marchio che le segna e le esclude, che sia un difetto fisico, un passato scomodo, la vecchiaia o, semplicemente, la povertà del loro stato. Allora come oggi, sono donne che lottano per essere adeguate e integrate, pur con il senso di un’oscura condanna. Ma è proprio da questo che nasce la loro unicità, il loro riconoscersi come motore della Storia. In un’epoca di cambiamenti e di prime rivendicazioni femminili e sociali, con stile scorrevole e modernissimo acume psicologico, l’autrice ci guida di volta in volta in una realtà urbana e operaia, provinciale e borghese, ma sempre con gli occhi di queste taciturne, instancabili, fedeli, che mai cessano di sentirsi “in perfetta armonia col proprio destino”.
-----------
Ada Negri, nata Lodi nel 1870 e morta a Milano nel 1945, fu la prima donna ammessa all’Accademia d’Italia. Autrice di poesie e prosa, negli anni venti sfiorò il Nobel per la letteratura (assegnato invece nel 1926 a Grazia Deledda). Le sue opere sono spesso di denuncia, in particolar modo sociale, in difesa delle classi più povere e sfruttate. Non è, la sua, una poesia didattica, che insegna, quanto, invece, parola che suggerisce e invita alla riflessione. Se molte sue liriche vennero musicate con successo da compositori del periodo, i racconti e la sua autobiografia, di potente intensità, rivelano una notevole modernità di stile e di scrittura. Dei suoi personaggi Ada Negri disse: “Vi è contenuta tanta parte di me, e posso dire che non una di quelle figure di donna che vi sono scolpite o sfumate mi è indifferente. Vissi con tutte, soffersi, amai, piansi con tutte”.
Il rapporto con la musica
Valentina Ferri, profonda conoscitrice della musica ci racconta che “Forse non molti sanno che Ada Negri ebbe un profondo rapporto con la musica: diverse delle sue liriche vennero infatti musicate da Francesco Paolo Tosti, che aveva già messo in musica alcune poesie di altri autori italiani del calibro di D’Annunzio, Carducci e Fogazzaro, oltre che di autori stranieri come Hugo e Verlaine. Le poesie di Ada Negri furono inoltre musicate tra gli altri anche da Ettore Patrizi, con cui l’autrice visse un’intensa storia d’amore, poi trasformatasi in una salda amicizia.”
A questo link sono elencate le poesie di Ada Negri che sono state musicate
Tra socialismo e fascismo
Nel primo decennio del Novecento Ada Negri fu vicina al socialismo riformista di Turati e di Anna Kuliscioff, definita come una “sorella ideale”. In realtà il socialismo della poetessa lodigiana, più che sul piano politico, si esplicitò nell’attenzione riservata alle figure sociali: non a caso la fabbrica fa sfondo a molte delle sue opere, a cominciare da diversi racconti de Le solitarie. La Negri nello stesso periodo fu anche cofondatrice insieme a Ersilia Majno dell’Unione Femminile e partecipò all’esperienza dell’Asilo Mariuccia, un rifugio per le donne che si prostituivano. Le sue poesie furono inoltre recensite e lodate da Benito Mussolini, suo grandissimo estimatore: non a caso nel 1940 Ada Negri fu l’unica donna ammessa all’Accademia d’Italia. In seguito alla guerra civile si distaccò dal fascismo, a cui tuttavia non aderì mai formalmente, e per avvicinarsi alla religione. La sua vicinanza al regime le provocò inoltre le accuse di figure come Gramsci, Pirandello e Serra e nel dopoguerra la critica la condannò a una damnatio memoriae che tuttavia non fu sufficiente a impedire che il suo valore poetico si trasmettesse fino ai giorni nostri.
Il legame con i telai
La madre di Ada Negri, Vittoria Cornalba, era una tessitrice che, dopo la morte del padre di Ada Giuseppe Negri, trovò un impiego come operaia. Nel 1896 inoltre, Ada sposò un industriale tessile di Biella, Giovanni Garlanda, dal quale ebbe due figlie: i due si separarono nel 1913. Questo legame con l’ambito tessile è fortemente presente in molte opere della poetessa lodigiana: non a caso la figura del telaio ricorre in diverse delle sue poesie, come Popolana, e in diversi racconti, compresi La promessa e Il crimine contenuti ne Le solitarie.
a cura di Ilaria Guidantoni