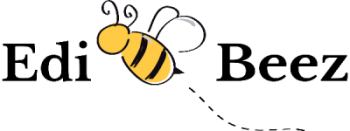Prosegue il viaggio di BeBeez attraverso le cantine che aderiscono al nuovo progetto del vino a marchio Terraelectae, all’interno del Chianti Rufina, zona a est di Firenze (si veda qui la prima parte nel precedente articolo di BeBeez).
La nuova tappa è al Castello di Nipozzano della famiglia Frescobaldi con una grande tenuta di 240 ettari vitati che racconta una storia che inizia nel Trecento, da quando la famiglia fiorentina ha cominciato a produrre vino, mantenendo ancora una gestione familiare per nulla scontata. In quest’area, dove si producono attualmente solo vini rossi, la continuità attuale è con la rivoluzione del 1974 quando Montesodi fu il pivot del progetto ante litteram con l’idea di sposare la personalità del vitigno e del luogo, senza rincorrere i grandi numeri. Oggi il gruppo rappresenta i diversi volti del territorio, con una produzione di olio su 70 ettari all’interno del consorzio Laudemio, una produzione di carne, Chianina e Angus, per il circuito della ristorazione, espressione di sintesi del Gruppo che unisce tutte le attività e l’hôtellerie.


Lavacchio è appartenuto alla famiglia Strozzi fino al 1978 quando è passato alla famiglia Lottero che fin dall’inizio ha optato per una scelta di agricoltura più sostenibile, certificandosi come azienda biologica nel 2000, mentre nel 2019 ha iniziato il percorso di certificazione biodinamica. La proprietà presenta anche la vecchia Villa Strozzi, ci ha raccontato Faye Lottero, giovane donna creativa, piena di iniziativa, che fin da bambina ha sognato di vederla restaurata.
Il suo progetto dovrà attendere ancora un po’ ma non è accantonato anche perché la dimora presenta una cappella consacrata che all’epoca era giubilare importante per il dipinto della Madonna del parto commissionato dalla famiglia Strozzi ad Antonio Veneziano, secondo l’attribuzione più accreditata, e ora nel santuario di Montefiesole, meta di pellegrinaggio da parte di coloro che hanno difficoltà ad avere figli.
L’eredità degli Strozzi è rappresentata anche da un cedro del Libano di trecento anni, simbolo di longevità del casato, strumento che in generale usavano i nobili, quello di piantare ambiti secolari, quale immagine di solidità e buon auspicio. Oggi la pianta è il simbolo dell’azienda non potendosi fregiare di quello degli Strozzi e non avendo uno stemma di famiglia.

Intorno all’azienda vinicola ruotano alcune attività, quali quella dell’Agriturismo con una ristorazione di qualità, uno dei punti di riferimento della zona; la tartufaia; e il laboratorio di ceramica dal 1980, oggi affidato a Massimo Innocenti, ex docente di arti visive all’Accademia delle Belle Arti di Firenze, che propone corsi di ceramica e realizzazione di pezzi unici. Figlio d’arte, il padre aveva fuso la ceramica fiorentina e con la tradizione di quella arabo-musulmana realizzando tra l’altro nel 1990 una collezione di 250 piatti per una moschea in Indonesia. Per quanto riguarda più direttamente la partecipazione al progetto Terraelectae, la scelta è caduta su Vigna Casanova, la vigna più vecchia dell’intera zona, del 1963, che i contadini hanno sempre chiamato “la vecchia in salita” dove è coltivato un clone di Sangiovese che potrebbe essere Brunello, concentrato nel calore e molto intenso nei sentori fruttati: l’idea di valorizzare questo cru c’era già e il nuovo marchio ha rappresentato l’occasione per esprimerne le potenzialità, ci ha raccontato Faye.

Con la Tenuta Bossi dei Marchesi Gondi facciamo un viaggio nella storia solo di questa nobile famiglia fiorentina, nata dal braccio De Filippi, citata già da Dante nel XVI canto del Paradiso annoverata tra le famiglie storiche della città. I Gondi sono nominati cavalieri nel 786 sotto Carlo Magno e nel Rinascimento furono battiloro, commercianti, banchieri e ricoprirono ruoli ecclesiastici di rilievo come ci ha raccontato Gerardo Gondi. Giuliano Gondi in particolare, per citare uno degli antenati illustri, parente di Lorenzo il Magnifico, fu banchiere del re Alfonso di Napoli assumendo un ruolo essenziale per la riappacificazione tra le città di Firenze e Napoli appunto. Suo nipote, Antonio fu nominato prima banchiere della dote di Caterina dei Medici quando si trasferì in Francia e poi della Corte sposando la figlia del Gran Ciambellano; di fatto introdusse la ‘fiorentinità’ Oltralpe. Fu inoltre colui che finanziò il viaggio di Giovanni da Verrazzano che scoprì la Baia di New York. I suoi figli furono Alberto Generale di Francia e suo fratello Pietro, Cardinale e Arcivescovo di Parigi, che officiò tra la l’altro la messa per Maria dei Medici, quando divenne regina di Francia.

Il legame della famiglia con la Francia è molto intimo, basti pensare che alcuni Gondi sono sepolti nell’abside di Notre Dame; mentre in Santa Maria Novella la loro cappella è quella a sinistra e fu disegnata da Sangallo come il Palazzo Gondi, nel centro di Firenze, sede oggi di eventi culturali. La famiglia insomma continua a tracciare un ponte tra Italia e Francia a vari livelli, dal vino alla cultura o meglio, potremmo dire, in un percorso nel quale il vino è una delle espressioni.
L’acquisto dell’azienda risale al 1592 quando i Gondi la rilevarono dalla famiglia Tolomei, sebbene avessero possedimenti in zona già a partire dall’Anno Mille. La Villa attuale ha un impianto quattrocentesco con vari rimaneggiamenti e una svolta arrivò quando la quadrisnonna di Gerardo vi giunse a metà dell’Ottocento. Proveniente da una famiglia francese di vigneron, rimasta vedova, non essendosi ambientata a Firenze, preferì la Rufina le cui colline le ricordavano la sua Francia ed ebbe l’idea di produrre grandi vini in grado di competere con quelli francesi. Fu una delle prime donne imprenditrici nel settore del vino e introdusse in Italia il savoir faire francese a cominciare dalla specializzazione del vigneto o la fermentazione in tini di cemento.
Creò qualcosa che potremmo definire un Chianti in stile Borgogna, antesignano della Riserva, a partire dall’individuazione dei limiti della ‘ricetta’ fissata dal barone Bettino Ricasoli, ovvero la scelta di uve a bacca bianca, la necessità di addomesticare il Sangiovese, vero cuore di questo vino, l’introduzione della bottiglia italica, variazione della bordolese in sostituzione del fiasco. I risultati arrivarono con il figlio Carlo che all’Expo francese del 1889 vinse alcuni premi.
La storia continua sul versante italiano mentre il ramo francese si estingue con Giovan Francesco Paolo, nemico del Cardinale Mazzarino che alla fine fu sconfitto e morì avvelenato, una storia che ebbe un qualche impatto, basti pensare che alcuni storici raccontano che se non fosse morto forse la stessa Rivoluzione francese non sarebbe stata necessaria. Insomma i Gondi hanno avuto un peso importante nelle vicende dei due paesi cugini, essendo tra l’altro gestori dell’eredità di Leonardo. Ora se è vero che queste vicende e molte altre appartengono al passato, il presente si nutre della memoria e mostra come il territorio della Rufina meriti attenzione perché riserva molte scoperte, attraverso case e casati, che il percorso di enoturismo dell’azienda svela, con un calendario di attività culturali, a cominciare dalla programmazione del “Jazz in fattoria” per il mese di luglio e agosto. Quanto alla vinicoltura il Vigneto Poggio Diamante è il testimone del progetto Terraelectae, e concentrando lo stile della casa, un’agricoltura tradizionale senza certificazioni biologiche per lasciarsi la libertà di intervento in caso di situazioni critiche, consapevoli del lato ‘umorale’ del Sangiovese, affiancato in azienda da vitigni internazionali come il Cabernet Sauvignon che negli anni Ottanta hanno introdotto per primi in Toscana, il Merlot, lo Chardonnay, il Sauvignon Blanc e naturalmente il locale Trebbiano per il Vinsanto ritenuto un gioiello di famiglia.

Selva Piana, unica azienda tra l’altro a produrre il Pomino bianco insieme a Frescobaldi, è attualmente gestita da Federico Giuntini Antinori Masseti che, ci ha raccontato, dopo la scomparsa del padre che era stato fattore per quarant’anni alla Fattoria Giuntini Antinori, fu adottato dalla famiglia per lasciare un’eredità di attività nel settore. L’azienda è stata un punto di riferimento importante per la zona soprattutto nel corso degli anni Ottanta quando ha tenuto testa alla difesa di un territorio che in quel momento stava soffrendo molto. La casa, corpo centrale della tenuta, si sviluppa intorno ad una delle torrette di avvistamento a protezione di Firenze – d’altronde anche Pontassieve nasce come borgo fortificato per la difesa del territorio – e diventa la residenza estiva dei vescovi fiorentini, ingrandendosi nel corso del Rinascimento. La residenza, prima proprietà degli Albizi e poi degli Scalambrone, dai quali viene acquistata da parte dei Giuntini, ha subito vari rimaneggiamenti ed è al centro di un piccolo sistema di case che oggi sono affittate. I Giuntini che ancora posseggono in linea diretta anche La Parrina in Maremma e Badia a Coltibuono, puntano molto sulla longevità dei vini perché elemento essenziale di attrattività per investitori e collezionisti.

Non è un caso infatti che, in occasione di una presentazione di vini ‘antichi’ abbiano concorso – insieme con Capezzana della zona di Carmignano – con un vino del 1980 ma si può risalire molto più indietro: abbiamo infatti avuto il privilegio di assaggiare una bottiglia del 1969, ancora vigorosa. L’attenzione da anni era stata focalizzata su un primo cru, Bucerchiati a cui è seguito Eichi, progetto nato in autonomia che poi è confluito nel progetto Terraelectae. A dire il vero l’idea originaria di Federico sul marchio era più rigorosa di quella approvata prevedendo l’impiego del Sangiovese in purezza, l’unicità della vigna ma anche la sua geolocalizzazione, oltre la coltivazione biologica e la vinificazione naturale. Non è un caso che avesse proposto una ‘gran selezione’ quando ancora il Chianti non si era fatto avanti. L’aspettativa sul marchio è che quello che ritiene il Sangiovese più equilibrato, la Rufina, possa venire valorizzato grazie ad una comunicazione appropriata complice un momento favorevole sia per il cambiamento climatico che favorisce questa zona sia per l’evoluzione del gusto e Selva Piana, dopo il Gruppo Frescobaldi, è certamente il nome più noto della zona, per cui può dare un segnale importante in tal senso.
a cura di Mila Fiorentini