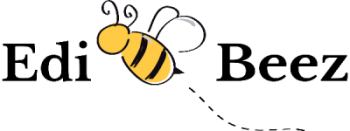Fausto Melotti, la ceramica al centro
Iscriviti alle nostre Newsletter
Iscriviti alle newsletter di BeBeez
Related Posts
Co-sponsors
Proposte di M&A e Club Deal
- CUCINE COMPONIBILIon 27 Aprile 2024 at 06:36
{p class='settore'}ARREDAMENTO{/p} {p class='codice'}320{/p} {p class='fatturato'}€ 50.000.000 - 75.000.000{/p} {p class='areageografica'}Centro-Nord Italia{/p} {p class='tipologia'}Acquisizioni{/p} {p class='cap'}mid{/p} {p class='specificheazienda'}Società italiana quotata, leader nella produzione e commercializzazione di porte per interni e nelle finestre, ha consolidato nel corso del tempo un business model fondato sia sul canale B2B che in quello B2C. Ha inoltre implementato una struttura internazionale per favorire l’espansione nei mercati esteri ove realizza il 30% dei propri ricavi. Sta perseguendo una strategia di crescita anche per vie esterne attuando un processo di diversificazione in segmenti di mercato contigui come quello delle cucine.{/p} {p class='target'}Si desidera acquisire società che producono cucine componibili con un fatturato da €5 a 30 milioni.Aree geografiche: Nord, Centro Italia e Campania.Tipologia di operazione ricercata: acquisizione almeno del 51% del capitale.{/p}
- REALTA' VIRTUALE E REALTA' AUMENTATAon 27 Aprile 2024 at 06:36
{p class='settore'}NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI{/p} {p class='codice'}196{/p} {p class='fatturato'}€ 10.000.000 - 15.000.000{/p} {p class='areageografica'}Italia{/p} {p class='tipologia'}Acquisizioni{/p} {p class='cap'}mid{/p} {p class='specificheazienda'}IMPORTANTE SOCIETA' MULTINAZIONALE, la cui attività si concentra su tecnologie all'avanguardia quali soluzioni 3D, Realtà Virtuale, Realtà Aumentata, IoT Industriale e CAD. La MISSION della società è aiutare le aziende e le organizzazioni ad innovare e creare valore attraverso le nuove frontiere digitali ed informatiche.{/p} {p class='target'}Si ricerca una azienda focalizzata su attività di consulenza "corporate" di tipo industriale o design industriale (ambito software), System Integrators in generale (ERP, CAD in primis). Dimensione ottimale fatturato 3/7 milioni. Ebitda positivo. Localizzazione preferibile: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Lazio. Operazione proposta: acquisizione totalità quote/azienda o maggioranza societaria.{/p}
- AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, PRODUZIONE SCHEDE, CABLAGGI, CAVI, ASSEMBLAGGIon 27 Aprile 2024 at 06:36
{p class='settore'}ELETTROTECNICA AUTOMAZIONE{/p} {p class='codice'}215{/p} {p class='fatturato'}€ 5.000.000 - 10.000.000{/p} {p class='areageografica'}Nord Italia{/p} {p class='tipologia'}Acquisizioni{/p} {p class='cap'}mid{/p} {p class='specificheazienda'}Azienda nota a livello nazionale nel proprio settore che si occupa di automazione industriale, produzione schede elettroniche, quadri elettrici, cablaggi, cavi, sensori, regolatori e sistemi elettronici di vario tipo, con ampio know how nelle fasi di progettazione iniziale ed assemblaggi finali. I prodotti realizzati trovano applicazione in numerosi e differenti settori sia in campo industriale che civile.{/p} {p class='target'}La società ricerca aziende terze operanti nel medesimo settore o complementari e affini, con le quali effettuare una potenziale acquisizione o fusione, in ottica di crescita, sinergie e sviluppo congiunto del nuovo Gruppo industriale.{/p}
- FORMAZIONE, E-LEARNING E RE-SKILLING DIGITALE DELLE AZIENDEon 27 Aprile 2024 at 06:36
{p class='settore'}FORMAZIONE{/p} {p class='codice'}322{/p} {p class='fatturato'}€ 400.000 - 600.000{/p} {p class='areageografica'}Nord Italia{/p} {p class='tipologia'}Cessioni{/p} {p class='cap'}small{/p} {p class='specificheazienda'}Come spin-off di una società di IT, in decenni di attività, ha sviluppato un’ampia libreria di corsi di formazione inerenti la ‘strumentazione digitale’ più trasversale alle aziende. La formazione proposta è on line/off line, certificata e accreditata, anche con accesso ai finanziamenti della Regione Lombardia e ai Fondi Interprofessionali. I contenuti progettati abbracciano sia il mondo Microsoft che Apple, nonché le soft skill manageriali. La società si è affermata come partner di riferimento per l’aggiornamento professionale delle risorse e l’acquisizione delle competenze digitali in ambito corporate.{/p} {p class='target'}I soci sono orientati alla cessione della totalità delle quote, assicurando al tempo stesso agli acquirenti la disponibilità ad un periodo di accompagnamento congruo.{/p}
- MOSTRE D'ARTE DIGITALI - REALTA' AUMENTATAon 27 Aprile 2024 at 06:36
{p class='settore'}INTRATTENIMENTO{/p} {p class='codice'}212{/p} {p class='fatturato'}€ 2.000.000 - 4.000.000 {/p} {p class='areageografica'}Nord Italia{/p} {p class='tipologia'}Cessioni{/p} {p class='cap'}small{/p} {p class='specificheazienda'}Società che opera nella produzione e realizzazione di esposizioni temporanee e mostre digitali. Utilizza tecnologie di realtà aumentata/virtuale per trasformare contenuti artistici e culturali in esperienze multimediali interattive, immersive e multisensoriali, di grande coinvolgimento emotivo. I contenuti realizzati dalla società sono stati acquistati da 3,5 milioni di consumatori in 12 nazioni in tutto il mondo.{/p} {p class='target'}La società sta ricercando un partner industriale per aumento di capitale da €1,3 mio in due tranche. Le risorse richieste saranno prevalentemente utilizzate per finanziare l’internazionalizzazione della società.{/p}
- AZIENDA LEADER NELLA PRODUZIONE DI DERIVATI DELL'UOVOon 27 Aprile 2024 at 06:36
{p class='settore'}ALIMENTARE{/p} {p class='codice'}246{/p} {p class='fatturato'}€ 5.000.000 - 7.000.000 {/p} {p class='areageografica'}Nord Italia{/p} {p class='tipologia'}Cessioni{/p} {p class='cap'}small{/p} {p class='specificheazienda'}La società si caratterizza per un assetto industriale up-to-date e flessibile: - il processo industriale è in grado di trasformare tutte le tipologie di prodotti legate all’uovo (albume, tuorlo e uovo intero), garantendo una capacità produttiva pari a 9 tonnellate al giorno di albume; - tecnologia proprietaria in quanto su disegno proprio e realizzata da diversi sub fornitori; - disponibilità di un impianto pilota per la messa a punto dei nuovi prodotti. L’azienda, in quanto leader nel settore dell’essicazione, fornisce un prodotto unico che consente di penetrare mercati B2B nazionali ma anche esteri, tramite agenti ed un funzionario aziendale, detenendo licenze ed autorizzazioni specifiche per vari paesi ed in particolare opera con una società commerciale in Svizzera . L’efficienza produttiva consente di soddisfare le maggiori aziende agroalimentari di diversi settori, tra cui dolciario, ittico, carne, mangimi per animali, nonché le industrie farmaceutiche, generando un processo controllato a 360°.{/p} {p class='target'}La società si rivolge a partner industriali che operano principalmente nel campo agroalimentare, in particolare nel settore avicolo, dolciario o alimentare, interessati a completare la filiera per una specifica expertise sul prodotto e disponibili a rilevare la totalità delle quote.{/p}

Partners
Tag
Cookie Policy
Cookie tecnici
Cookie Google Analytics
Cookie utili a costruire statistiche anonime sul comportamento degli utenti nel sito.
Cookie tecnici
Cookie utili al funzionamento del sito.
EdiBeez srl
C.so Italia 22 - 20122 - Milano
C.F. | P.IVA 09375120962
Aut. Trib. Milano n. 102
del 3 aprile 2013
Capitale di rischio
Imprese
Analisi&Rubriche
Gestione dati personali
Informazioni sul sito
Powered by Olomedia © 2021